Items
-
 Mentre frequentava le scuole di Chieri, nelle vacanze del 1832 il parroco di Castelnuovo Don Dassano lo vide custodire due vacche al pascolo col libro di un autore classico in mano. Conoscendo che Giovanni desiderava avere ripetizioni, si offrì di fargli delle lezioni sui classici latini. Giovanni lo ripagò facendogli un po' da stalliere e accudendo il suo cavallo. In questo modo ebbe anche l'occasione di diventare un buon cavallerizzo (cf MB 1, 273).
Mentre frequentava le scuole di Chieri, nelle vacanze del 1832 il parroco di Castelnuovo Don Dassano lo vide custodire due vacche al pascolo col libro di un autore classico in mano. Conoscendo che Giovanni desiderava avere ripetizioni, si offrì di fargli delle lezioni sui classici latini. Giovanni lo ripagò facendogli un po' da stalliere e accudendo il suo cavallo. In questo modo ebbe anche l'occasione di diventare un buon cavallerizzo (cf MB 1, 273). -
 Giovanni fu accolto nella casa del sarto e organista Giovanni Roberto, il quale gli insegnò la sua arte e anche la musica e il canto. Da lui imparò a suonare il cembalo e il violino. Giovannino ne ripagava l'ospitalità aiutandolo nel taglio e nel cucito (cf MB 1, 221; 232-233). Contemporaneamente, per guadagnarsi qualche soldo e comperarsi i libri, frequentò l'officina del fabbro Evasio Savio e imparò a maneggiare il mantice e l'incudine. Si preparava così, inconsciamente, al suo futuro di apostolo nelle scuole professionali (cf MB 1,234).
Giovanni fu accolto nella casa del sarto e organista Giovanni Roberto, il quale gli insegnò la sua arte e anche la musica e il canto. Da lui imparò a suonare il cembalo e il violino. Giovannino ne ripagava l'ospitalità aiutandolo nel taglio e nel cucito (cf MB 1, 221; 232-233). Contemporaneamente, per guadagnarsi qualche soldo e comperarsi i libri, frequentò l'officina del fabbro Evasio Savio e imparò a maneggiare il mantice e l'incudine. Si preparava così, inconsciamente, al suo futuro di apostolo nelle scuole professionali (cf MB 1,234). -
 Secondo l'uso del tempo, anche Francesco Bosco, papà di Giovanni, venne seppellito in chiesa, e precisamente nella parrocchia dedicata a San Pietro, in Castelnuovo. Questa però era ormai cadente e impraticabile, cosicché si decise di costruire un cimitero nuovo, che fu inaugurato nel giugno del 1817. La chiesa di san Pietro venne demolita, e i cadaveri raccolti in una fossa comune. Così andò disperso quello di Francesco Bosco. Sulla via Argenterò venne eretto un pilone dedicato a san Pietro, per ricordare che fino al 1817 sorgeva in quel luogo l'antica parrocchia dedicata al Vicario di Cristo.
Secondo l'uso del tempo, anche Francesco Bosco, papà di Giovanni, venne seppellito in chiesa, e precisamente nella parrocchia dedicata a San Pietro, in Castelnuovo. Questa però era ormai cadente e impraticabile, cosicché si decise di costruire un cimitero nuovo, che fu inaugurato nel giugno del 1817. La chiesa di san Pietro venne demolita, e i cadaveri raccolti in una fossa comune. Così andò disperso quello di Francesco Bosco. Sulla via Argenterò venne eretto un pilone dedicato a san Pietro, per ricordare che fino al 1817 sorgeva in quel luogo l'antica parrocchia dedicata al Vicario di Cristo. -
 In un cortile interno di via Marconi vi è la casa rustica della famiglia Allamano. Il cortile e il caseggiato sono abbastanza grandi e denotano una certa agiatezza. La stalla (oggi rifatta sullo stile antico) è capace. Di fianco, una cucina ampia con un grande camino e, a lato, due fornelli per cuocere le vivande. Al piano superiore tre grandi stanze con le tipiche travature di legno, arredate con antichi mobili dell'800. Qui nacque Giuseppe il 21 gennaio 1851. Era nipote di san Giuseppe Cafasso, ed ebbe la fortuna di compiere gli studi sotto la guida di Don Bosco, all'Oratorio. Ordinato prete, fu nominato rettore del santuario della Consolata e ne fece uno dei maggiori centri piemontesi di pietà mariana. Rinnovò il Convitto e fondò l'Istituto Missioni della Consolata e delle Suore Missionarie della Consolata.
In un cortile interno di via Marconi vi è la casa rustica della famiglia Allamano. Il cortile e il caseggiato sono abbastanza grandi e denotano una certa agiatezza. La stalla (oggi rifatta sullo stile antico) è capace. Di fianco, una cucina ampia con un grande camino e, a lato, due fornelli per cuocere le vivande. Al piano superiore tre grandi stanze con le tipiche travature di legno, arredate con antichi mobili dell'800. Qui nacque Giuseppe il 21 gennaio 1851. Era nipote di san Giuseppe Cafasso, ed ebbe la fortuna di compiere gli studi sotto la guida di Don Bosco, all'Oratorio. Ordinato prete, fu nominato rettore del santuario della Consolata e ne fece uno dei maggiori centri piemontesi di pietà mariana. Rinnovò il Convitto e fondò l'Istituto Missioni della Consolata e delle Suore Missionarie della Consolata. -
 Tra i suoi monumenti più cari Castelnuovo conserva anche la casa nella quale nacque e abitò san Giuseppe Cafasso. Questi fu chiamato la perla del clero italiano e fu guida e maestro dei giovani sacerdoti al Convitto Ecclesiastico di Torino. Grande amico e benefattore di Don Bosco, lo orientò con sicurezza verso la sua missione giovanile, e non gli lasciò mai mancare né i saggi consigli né gli aiuti finanziari, di cui Don Bosco aveva continuo bisogno. Questa cappellina è stata ricavata da una stanza abitata dal Cafasso, e in essa 0 santo è ricordato e invocato.
Tra i suoi monumenti più cari Castelnuovo conserva anche la casa nella quale nacque e abitò san Giuseppe Cafasso. Questi fu chiamato la perla del clero italiano e fu guida e maestro dei giovani sacerdoti al Convitto Ecclesiastico di Torino. Grande amico e benefattore di Don Bosco, lo orientò con sicurezza verso la sua missione giovanile, e non gli lasciò mai mancare né i saggi consigli né gli aiuti finanziari, di cui Don Bosco aveva continuo bisogno. Questa cappellina è stata ricavata da una stanza abitata dal Cafasso, e in essa 0 santo è ricordato e invocato. -
 Ammiriamo uno scorcio del paese con la canonica e le case che si affacciano sulla piazza. Il parroco di allora, Don Dassano, era un uomo dotto, caritatevole e santo, e Giovanni ne farà presto l'esperienza, come diremo. Egli tuttavia teneva un contegno sostenuto, specie con i fanciulli, e Giovanni ne soffriva, perché sentiva vivo il desiderio di avvicinarlo per ascoltare la sua parola. Si rammaricava di questo con la mamma e le diceva: Se io fossi prete, mi avvicinerei ai fanciulli, li chiamerei intorno a me, per dir loro buone parole e vorrei aiutarli e farmi amare da loro. Se sarò prete, voglio consacrare tutta la mia vita per i fanciulli (cf MB 1,227). Un programma che realizzerà in pieno.
Ammiriamo uno scorcio del paese con la canonica e le case che si affacciano sulla piazza. Il parroco di allora, Don Dassano, era un uomo dotto, caritatevole e santo, e Giovanni ne farà presto l'esperienza, come diremo. Egli tuttavia teneva un contegno sostenuto, specie con i fanciulli, e Giovanni ne soffriva, perché sentiva vivo il desiderio di avvicinarlo per ascoltare la sua parola. Si rammaricava di questo con la mamma e le diceva: Se io fossi prete, mi avvicinerei ai fanciulli, li chiamerei intorno a me, per dir loro buone parole e vorrei aiutarli e farmi amare da loro. Se sarò prete, voglio consacrare tutta la mia vita per i fanciulli (cf MB 1,227). Un programma che realizzerà in pieno. -
 Un angolo del paese conserva tuttora le caratteristiche del tempo di Don Bosco e del Cafasso. Qui viveva un certo numero di famiglie benestanti del paese i cui figli, in un primo tempo, deridevano Giovannino per i suoi abiti poveri e dimessi (cf MB 1, 221).
Un angolo del paese conserva tuttora le caratteristiche del tempo di Don Bosco e del Cafasso. Qui viveva un certo numero di famiglie benestanti del paese i cui figli, in un primo tempo, deridevano Giovannino per i suoi abiti poveri e dimessi (cf MB 1, 221). -
 Castelnuovo d'Asti è un popoloso e importante centro viti-vinicolo. Oltre che di Don Bosco, è patria di san Giuseppe Cafasso, del canonico Giuseppe Allamano (fondatore dei Missionari della Consolata) e del cardinale Giovanni Cagliero, capo della prima spedizione missionaria salesiana.
Castelnuovo d'Asti è un popoloso e importante centro viti-vinicolo. Oltre che di Don Bosco, è patria di san Giuseppe Cafasso, del canonico Giuseppe Allamano (fondatore dei Missionari della Consolata) e del cardinale Giovanni Cagliero, capo della prima spedizione missionaria salesiana. -
 Durante la sua permanenza al Sussambrino avvenne un altro episodio significativo. A Crivelle, frazione di Buttigliera, si celebrava la festa di san Bartolomeo; un suo zio, priore della festa, Io invitò a intervenire alle sacre funzioni. Dopo il pranzo, fu invitato a suonare il violino, strumento che gli piaceva molto e nel quale se la cavava bene. Accettò, sebbene con riluttanza. Ma ad un tratto si accorse che nell'aia una piccola folla danzava al suono del suo violino. La festa prendeva così un carattere profano che Giovannino non potè assolutamente tollerare. Restituì immediatamente il violino che gli era stato imprestato, e tornato a casa fece a pezzi il suo, che pure gli era caro (cf MB 1, 419s).
Durante la sua permanenza al Sussambrino avvenne un altro episodio significativo. A Crivelle, frazione di Buttigliera, si celebrava la festa di san Bartolomeo; un suo zio, priore della festa, Io invitò a intervenire alle sacre funzioni. Dopo il pranzo, fu invitato a suonare il violino, strumento che gli piaceva molto e nel quale se la cavava bene. Accettò, sebbene con riluttanza. Ma ad un tratto si accorse che nell'aia una piccola folla danzava al suono del suo violino. La festa prendeva così un carattere profano che Giovannino non potè assolutamente tollerare. Restituì immediatamente il violino che gli era stato imprestato, e tornato a casa fece a pezzi il suo, che pure gli era caro (cf MB 1, 419s). -
 Quando giunse alla portata degli oggetti appesi alla cima, fu un applauso generale. Giovanni prese la borsa con 20 lire, che gli servivano per i suoi studi, un salsicciotto e un fazzoletto e lasciò il resto perché il gioco potesse continuare. Poi scese rapidamente, scomparendo in mezzo alla folla (cf MB 1, 235-236).
Quando giunse alla portata degli oggetti appesi alla cima, fu un applauso generale. Giovanni prese la borsa con 20 lire, che gli servivano per i suoi studi, un salsicciotto e un fazzoletto e lasciò il resto perché il gioco potesse continuare. Poi scese rapidamente, scomparendo in mezzo alla folla (cf MB 1, 235-236). -
 A Montafia, per la festa del paese, era stato innalzato l'albero della cuccagna, con molti bei premi. Consisteva in un tronco altissimo, liscio e unto, difficilissimo da scalare. Molti giovani avevano inutilmente tentato la prova, scivolando a terra tra le risate generali. Giovanni studiò bene le difficoltà; poi, risoluto e calmo, volle tentare. Iniziata la scalata con tranquillità, di tanto in tanto si fermava a prendere fiato sedendosi sui calcagni. La gente ridacchiava, aspettando di vederlo scivolare giù da un momento all'altro, ma Giovanni saliva sempre più in alto. Allora si fece un silenzio pieno di attesa.
A Montafia, per la festa del paese, era stato innalzato l'albero della cuccagna, con molti bei premi. Consisteva in un tronco altissimo, liscio e unto, difficilissimo da scalare. Molti giovani avevano inutilmente tentato la prova, scivolando a terra tra le risate generali. Giovanni studiò bene le difficoltà; poi, risoluto e calmo, volle tentare. Iniziata la scalata con tranquillità, di tanto in tanto si fermava a prendere fiato sedendosi sui calcagni. La gente ridacchiava, aspettando di vederlo scivolare giù da un momento all'altro, ma Giovanni saliva sempre più in alto. Allora si fece un silenzio pieno di attesa. -
 Durante l'estate Giovanni aveva l'incarico di portare al pascolo le mucche, che spesso mentre egli era assorto nella lettura, si sbandavano. Rosa Febbraro, ragazzetta di dieci anni, le rincorreva e gliele riportava: Ma perché le porti al pascolo se poi non le guardi?. Devo studiare, Rosa, e ogni tanto la mente mi scappa. È vero che diventerai prete?. Sì. Allora, se vuoi, le mucche te le guardo io!. I suoi occhi si spingevano sempre lontano, inseguendo la visione del sogno che non lo abbandonava mai.
Durante l'estate Giovanni aveva l'incarico di portare al pascolo le mucche, che spesso mentre egli era assorto nella lettura, si sbandavano. Rosa Febbraro, ragazzetta di dieci anni, le rincorreva e gliele riportava: Ma perché le porti al pascolo se poi non le guardi?. Devo studiare, Rosa, e ogni tanto la mente mi scappa. È vero che diventerai prete?. Sì. Allora, se vuoi, le mucche te le guardo io!. I suoi occhi si spingevano sempre lontano, inseguendo la visione del sogno che non lo abbandonava mai. -
 Il lavoro di cantina richiedeva molta attenzione e diligenza e a Giovanni spettava la ripulitura dei tini, controllare la fermentazione e al momento giusto spillare e travasare il vino, che veniva stivato nelle botti collocate in fresche cantine, come quelle della cascina, fino alla vendita. Prima di tornare a Chieri per gli studi, Giovanni aiutava il fratello Giuseppe in questo rito faticoso, ma anche pieno di gioia.
Il lavoro di cantina richiedeva molta attenzione e diligenza e a Giovanni spettava la ripulitura dei tini, controllare la fermentazione e al momento giusto spillare e travasare il vino, che veniva stivato nelle botti collocate in fresche cantine, come quelle della cascina, fino alla vendita. Prima di tornare a Chieri per gli studi, Giovanni aiutava il fratello Giuseppe in questo rito faticoso, ma anche pieno di gioia. -
 La vinificazione era fatta secondo una precisa tradizione, ma sfruttava tecnologie molto povere. La pigiatura veniva eseguita con i piedi per ottenere il mosto, che si lasciava fermentare una ventina di giorni in capaci tini o botti. Giovanni dava il suo generoso contributo alla pigiatura delle uve del fratello, ma anche presso i contadini vicini, per avere qualche soldo per continuare gli studi.
La vinificazione era fatta secondo una precisa tradizione, ma sfruttava tecnologie molto povere. La pigiatura veniva eseguita con i piedi per ottenere il mosto, che si lasciava fermentare una ventina di giorni in capaci tini o botti. Giovanni dava il suo generoso contributo alla pigiatura delle uve del fratello, ma anche presso i contadini vicini, per avere qualche soldo per continuare gli studi. -
 Finalmente a ottobre la vendemmia. Ci si avvaleva della collaborazione ben retribuita di uomini e donne per aiutare i componenti della famiglia, tanto era gravoso il lavoro che doveva essere terminato prima delle piogge autunnali. Quasi per alleviare la fatica, i canti dei vendemmiatori e delle vendemmiatrìci si intrecciavano attraverso le colline, e a sera musica e balli concludevano la fatica. I grappoli venivano raccolti delicatamente in ceste di vimini e portati nella bigoncia.
Finalmente a ottobre la vendemmia. Ci si avvaleva della collaborazione ben retribuita di uomini e donne per aiutare i componenti della famiglia, tanto era gravoso il lavoro che doveva essere terminato prima delle piogge autunnali. Quasi per alleviare la fatica, i canti dei vendemmiatori e delle vendemmiatrìci si intrecciavano attraverso le colline, e a sera musica e balli concludevano la fatica. I grappoli venivano raccolti delicatamente in ceste di vimini e portati nella bigoncia. -
 Nelle Memorie Biografiche si parla delle carestie che infierirono sulle popolazioni del Piemonte, durante la giovinezza di Don Bosco. Esse erano causate sovente dalla brina, dalla siccità e dalla grandine. La brina o il gelo nella tarda primavera bruciavano i teneri germogli delle viti e delle piante da frutta. Un altro grave pericolo era costituito dai grandi temporali estivi. In pochi secondi la grandine poteva distruggere il raccolto di un anno. Ecco una desolante immagine dei vigneti della cascina Sussambrino dopo una di queste tremende grandinate (1984). Ai contadini, non restava che confidare nella divina Provvidenza.
Nelle Memorie Biografiche si parla delle carestie che infierirono sulle popolazioni del Piemonte, durante la giovinezza di Don Bosco. Esse erano causate sovente dalla brina, dalla siccità e dalla grandine. La brina o il gelo nella tarda primavera bruciavano i teneri germogli delle viti e delle piante da frutta. Un altro grave pericolo era costituito dai grandi temporali estivi. In pochi secondi la grandine poteva distruggere il raccolto di un anno. Ecco una desolante immagine dei vigneti della cascina Sussambrino dopo una di queste tremende grandinate (1984). Ai contadini, non restava che confidare nella divina Provvidenza. -
 I vigneti insieme alla stalla, erano la più importante fonte di risorse della cascina. Perciò la viticoltura costituiva la parte preponderante del faticoso lavoro agrìcolo. A febbraio bisognava potare i tralci improduttivi, zappare o vangare i filari per tenerli sgombri da erbacce; a giugno cimare i pampini infruttiferi, irrorare i tralci, dare lo zolfo. Una ricchezza tanto importante doveva anche essere custodita. Così Giovanni si trovò a compiere questo servizio nei vigneti lavorati dal fratello Giuseppe e dall'amico Turco. Divenuto prete, Don Bosco dirà un po' scherzosamente: I miei studi li ho fatti nella vigna di Giuseppe Turco, alla Renenta (MB 1, 424).
I vigneti insieme alla stalla, erano la più importante fonte di risorse della cascina. Perciò la viticoltura costituiva la parte preponderante del faticoso lavoro agrìcolo. A febbraio bisognava potare i tralci improduttivi, zappare o vangare i filari per tenerli sgombri da erbacce; a giugno cimare i pampini infruttiferi, irrorare i tralci, dare lo zolfo. Una ricchezza tanto importante doveva anche essere custodita. Così Giovanni si trovò a compiere questo servizio nei vigneti lavorati dal fratello Giuseppe e dall'amico Turco. Divenuto prete, Don Bosco dirà un po' scherzosamente: I miei studi li ho fatti nella vigna di Giuseppe Turco, alla Renenta (MB 1, 424). -
 Ai piedi della collina esiste tuttora una polla di acqua sorgiva detta Renenta. Si trova a circa metà strada tra i Becchi e Castelnuovo. Ad essa attingevano acqua per gli usi domestici e per il bestiame, tutti i contadini di Morialdo durante il periodo di siccità. A questa fontana si ristorava anche Giovannino Bosco, quando andava e tornava da scuola, percorrendo la polverosa strada carraia. Una breve tappa, qualche sorsata d'acqua fresca, una rinfrescata al viso e ai piedi polverosi per togliersi la calura di dosso. Era veramente una benedizione del Signore, che egli non mancava mai di ringraziare.
Ai piedi della collina esiste tuttora una polla di acqua sorgiva detta Renenta. Si trova a circa metà strada tra i Becchi e Castelnuovo. Ad essa attingevano acqua per gli usi domestici e per il bestiame, tutti i contadini di Morialdo durante il periodo di siccità. A questa fontana si ristorava anche Giovannino Bosco, quando andava e tornava da scuola, percorrendo la polverosa strada carraia. Una breve tappa, qualche sorsata d'acqua fresca, una rinfrescata al viso e ai piedi polverosi per togliersi la calura di dosso. Era veramente una benedizione del Signore, che egli non mancava mai di ringraziare. -
 La cascina è collocata sulla collina, nella regione Sussambrino. Là esistevano ricchi vigneti, tra cui la vigna di Giuseppe Turco, amico del chierico Bosco. A lui Giovanni, mentre custodivano insieme le uve, aveva palesato confidenzialmente lo scopo per cui voleva farsi sacerdote: — Mi piacerebbe raccogliere attorno a me giovani poveri e abbandonati per educarli cristianamente ed istruirli. A lui raccontò il sogno fatto al Sussambrino: la valle sottostante si era mutata nella città di Torino, nelle cui strade e piazze correvano turbe di ragazzi schiamazzando, gridando e bestemmiando. Anche questa volta, come nel sogno di nove anni, il Signore maestoso e la Signora gli indicarono il comportamento da tenere per traformare quei ragazzacci in bravi cristiani (cf MB 1, 424).
La cascina è collocata sulla collina, nella regione Sussambrino. Là esistevano ricchi vigneti, tra cui la vigna di Giuseppe Turco, amico del chierico Bosco. A lui Giovanni, mentre custodivano insieme le uve, aveva palesato confidenzialmente lo scopo per cui voleva farsi sacerdote: — Mi piacerebbe raccogliere attorno a me giovani poveri e abbandonati per educarli cristianamente ed istruirli. A lui raccontò il sogno fatto al Sussambrino: la valle sottostante si era mutata nella città di Torino, nelle cui strade e piazze correvano turbe di ragazzi schiamazzando, gridando e bestemmiando. Anche questa volta, come nel sogno di nove anni, il Signore maestoso e la Signora gli indicarono il comportamento da tenere per traformare quei ragazzacci in bravi cristiani (cf MB 1, 424). -
 In una cascina c'è sempre da fare, soprattutto quando le braccia sono poche e non si vuol pesare sugli altri. Anche per ripagare in qualche modo l'ospitalità e il cibo offertogli dal fratello, Giovanni si rendeva sempre disponibile per qualsiasi genere di lavoro (cf MB 1, 238). 11 busto collocato sul muro del rustico deUa cascina Sussambrino ricorda la industriosa presenza dello studente-contadino.
In una cascina c'è sempre da fare, soprattutto quando le braccia sono poche e non si vuol pesare sugli altri. Anche per ripagare in qualche modo l'ospitalità e il cibo offertogli dal fratello, Giovanni si rendeva sempre disponibile per qualsiasi genere di lavoro (cf MB 1, 238). 11 busto collocato sul muro del rustico deUa cascina Sussambrino ricorda la industriosa presenza dello studente-contadino. -
 Un paesaggio incantevole, una bellissima strada: ma sempre qualcosa da percorrere a piedi per Giovanni, e soprattutto d'inverno la poesia era certo molto minore!
Un paesaggio incantevole, una bellissima strada: ma sempre qualcosa da percorrere a piedi per Giovanni, e soprattutto d'inverno la poesia era certo molto minore! -
 La bellezza e tranquillità del posto, la relativa vicinanza di questa cascina a Castelnuovo (circa 2 km), e soprattutto l'armonia familiare furono certamente un grandissimo aiuto per Giovanni.
La bellezza e tranquillità del posto, la relativa vicinanza di questa cascina a Castelnuovo (circa 2 km), e soprattutto l'armonia familiare furono certamente un grandissimo aiuto per Giovanni. -
 Poiché il fratello Giuseppe aveva preso in affitto un podere chiamato il Sussambrino, Giovanni andò a vivere con lui, insieme a mamma Margherita, che alternava la sua residenza tra questa nuova abitazione e i Becchi, secondo l'esigenza dei lavori campestri e dei raccolti. Anche Giovanni talora si ritirava ai Becchi, e nei giorni festivi istruiva i ragazzi del borgo nel catechismo e insegnava loro a leggere e a scrivere (cf MB 1, 279).
Poiché il fratello Giuseppe aveva preso in affitto un podere chiamato il Sussambrino, Giovanni andò a vivere con lui, insieme a mamma Margherita, che alternava la sua residenza tra questa nuova abitazione e i Becchi, secondo l'esigenza dei lavori campestri e dei raccolti. Anche Giovanni talora si ritirava ai Becchi, e nei giorni festivi istruiva i ragazzi del borgo nel catechismo e insegnava loro a leggere e a scrivere (cf MB 1, 279). -
 In questo luogo sorgeva la scuola frequentata da Giuseppe Cafasso e da Giovanni Bosco. Poi fu demolita e sostituita da quella che vediamo ora. E primo professore di Giovannino fu Don Virano, un ottimo insegnante. Ma presto fu nominato parroco e venne sostituito da Don Moglia. Un brav'uomo, ma incapace di tenere la disciplina e convinto che dalle borgate, e specialmente dai Becchi, non potesse venire niente di buono. Questo pregiudizio, ripetutamente manifestato, fece soffrire non poco Giovannino; gli stessi compagni lo prendevano in giro, anche per i suoi abiti goffi e rattoppati (cf MB 1, 229-232).
In questo luogo sorgeva la scuola frequentata da Giuseppe Cafasso e da Giovanni Bosco. Poi fu demolita e sostituita da quella che vediamo ora. E primo professore di Giovannino fu Don Virano, un ottimo insegnante. Ma presto fu nominato parroco e venne sostituito da Don Moglia. Un brav'uomo, ma incapace di tenere la disciplina e convinto che dalle borgate, e specialmente dai Becchi, non potesse venire niente di buono. Questo pregiudizio, ripetutamente manifestato, fece soffrire non poco Giovannino; gli stessi compagni lo prendevano in giro, anche per i suoi abiti goffi e rattoppati (cf MB 1, 229-232). -
 Nell'inverno del 1830 incominciò a frequentare le scuole di Castelnuovo. Così appariva d'inverno il tratto di campagna che Giovanni doveva percorrere quattro volte al giorno. Per le difficoltà di questo cammino, mamma Margherita decise di cercargli un alloggio a Castelnuovo. Lo trovò presso un sarto, Giovanni Roberto (cf MB 1, 219s).
Nell'inverno del 1830 incominciò a frequentare le scuole di Castelnuovo. Così appariva d'inverno il tratto di campagna che Giovanni doveva percorrere quattro volte al giorno. Per le difficoltà di questo cammino, mamma Margherita decise di cercargli un alloggio a Castelnuovo. Lo trovò presso un sarto, Giovanni Roberto (cf MB 1, 219s). -
 L'inserimento nel nuovo ambiente, gli costò molti sacrifici. A questo si aggiunga la fatica gravosa di andare e venire da casa quattro volte al giorno, il che significava ogni giorno 20 chilometri a piedi.
L'inserimento nel nuovo ambiente, gli costò molti sacrifici. A questo si aggiunga la fatica gravosa di andare e venire da casa quattro volte al giorno, il che significava ogni giorno 20 chilometri a piedi. -
 Morto il suo benefattore, Giovanni tornò dai suoi. Nonostante le molte difficoltà, dovute anche al fatto che l'anno scolastico era ormai avviato, verso il Natale del 1830 potè cominciare a frequentare le scuole di Castelnuovo (cf MB 1, 219).
Morto il suo benefattore, Giovanni tornò dai suoi. Nonostante le molte difficoltà, dovute anche al fatto che l'anno scolastico era ormai avviato, verso il Natale del 1830 potè cominciare a frequentare le scuole di Castelnuovo (cf MB 1, 219). -
 Questo voleva dire per Giovannino rifare sconsolato e col pianto nel cuore quella strada che tante volte aveva percorso pieno di gioia e di speranza.
Questo voleva dire per Giovannino rifare sconsolato e col pianto nel cuore quella strada che tante volte aveva percorso pieno di gioia e di speranza. -
 Un improvviso attacco cardiaco aveva lasciato Don Calosso privo di parola e semiparalizzato. Accorso al capezzale del morente, Giovanni ricevette da lui la chiave di uno scrigno in cui custodiva gelosamente i suoi risparmi. Quei soldi gli sarebbero serviti per continuare gli studi. Tale era stata la promessa e l'ultimo desiderio di Don Calosso. Ma di fronte alle richieste dei parenti del defunto, Giovanni vi rinunciò con dignità, confidando solo nella Provvidenza (cf MB 1, 216-218).
Un improvviso attacco cardiaco aveva lasciato Don Calosso privo di parola e semiparalizzato. Accorso al capezzale del morente, Giovanni ricevette da lui la chiave di uno scrigno in cui custodiva gelosamente i suoi risparmi. Quei soldi gli sarebbero serviti per continuare gli studi. Tale era stata la promessa e l'ultimo desiderio di Don Calosso. Ma di fronte alle richieste dei parenti del defunto, Giovanni vi rinunciò con dignità, confidando solo nella Provvidenza (cf MB 1, 216-218). -
 In questa stanza gli studi di Giovanni progredivano rapidamente e bene. A Natale ho messo mano alla grammatica latina. A Pasqua iniziai le traduzioni. Facevo tanto progresso in un giorno col cappellano, quanto ne avrei fatto a casa in una settimana. Quell'uomo di Dio più volte mi disse: Non darti pensiero del tuo avvenire. Finché vivo non ti lascerò mancare nulla. E se muoio prowederò a te ugualmente (MB 40).
In questa stanza gli studi di Giovanni progredivano rapidamente e bene. A Natale ho messo mano alla grammatica latina. A Pasqua iniziai le traduzioni. Facevo tanto progresso in un giorno col cappellano, quanto ne avrei fatto a casa in una settimana. Quell'uomo di Dio più volte mi disse: Non darti pensiero del tuo avvenire. Finché vivo non ti lascerò mancare nulla. E se muoio prowederò a te ugualmente (MB 40). -
 Nella sua povertà e semplicità, essa vanta grandissimi privilegi che non ebbero cattedrali illustri e artistiche. Vennero a pregare e la frequentarono tre grandi santi: il Cafasso, il Savio e Don Bosco. Nei quasi 11 anni che il Savio abitò a Morialdo, qui veniva a pregare e a servire la Messa al Cappellano dell'umile chiesetta.
Nella sua povertà e semplicità, essa vanta grandissimi privilegi che non ebbero cattedrali illustri e artistiche. Vennero a pregare e la frequentarono tre grandi santi: il Cafasso, il Savio e Don Bosco. Nei quasi 11 anni che il Savio abitò a Morialdo, qui veniva a pregare e a servire la Messa al Cappellano dell'umile chiesetta. -
 La chiesa officiata da Don Calosso era ed è dedicata a san Pietro. Per sdebitarsi almeno in parte dell'ospitalità e dell'insegnamento, Giovanni si prestò come sacrista e campanaro. Sulla porta di questa chiesa Giovanni aveva incontrato per la prima volta il chierico Cafasso. Essendo la sagra della borgata si era offerto per accompagnarlo a vedere la festa, e da lui ebbe in risposta la storica frase: Gli spettacoli dei preti sono le funzioni di chiesa (cf MB 1, 279). Don Giuseppe Cafasso sarebbe poi diventato suo direttore spirituale e uno dei suoi più grandi amici e benefattori (ci MB 1, 186).
La chiesa officiata da Don Calosso era ed è dedicata a san Pietro. Per sdebitarsi almeno in parte dell'ospitalità e dell'insegnamento, Giovanni si prestò come sacrista e campanaro. Sulla porta di questa chiesa Giovanni aveva incontrato per la prima volta il chierico Cafasso. Essendo la sagra della borgata si era offerto per accompagnarlo a vedere la festa, e da lui ebbe in risposta la storica frase: Gli spettacoli dei preti sono le funzioni di chiesa (cf MB 1, 279). Don Giuseppe Cafasso sarebbe poi diventato suo direttore spirituale e uno dei suoi più grandi amici e benefattori (ci MB 1, 186). -
 Addossata alla chiesa di Morialdo c'era la casa canonica. Là avvenne il primo incontro confidenziale tra Giovanni e Don Calosso. Il buon sacerdote si rese subito conto di avere a che fare con un ragazzo di doti non comuni e di una straordinaria forza di volontà. Volle parlare con la madre (cf MB 1, 179s) e s'impegnò a dare lezioni al ragazzo. Quella casa divenne familiare al contadinello dei Becchi; anzi, poco tempo dopo quell'incontro accettò l'invito di stabilirsi nella canonica stessa, per attendere agli studi con maggiore assiduità (cf MB 1, 214).
Addossata alla chiesa di Morialdo c'era la casa canonica. Là avvenne il primo incontro confidenziale tra Giovanni e Don Calosso. Il buon sacerdote si rese subito conto di avere a che fare con un ragazzo di doti non comuni e di una straordinaria forza di volontà. Volle parlare con la madre (cf MB 1, 179s) e s'impegnò a dare lezioni al ragazzo. Quella casa divenne familiare al contadinello dei Becchi; anzi, poco tempo dopo quell'incontro accettò l'invito di stabilirsi nella canonica stessa, per attendere agli studi con maggiore assiduità (cf MB 1, 214). -
 La borgata di Morialdo, formata da piccole frazioni e da cascine sparse tra le verdi colline, comprendeva anche i casolari dei Becchi che confinavano con Capriglio. Il cappellano era Don Calosso, che aveva rivolto a Giovanni l'invito di andarlo a trovare. Il ragazzo aderì e percorrendo due chilometri di strada, giunse di buon mattino a Morialdo. Quel giorno, una nuova speranza si accese nel suo cuore: finalmente avrebbe potuto studiare sul serio e sotto la guida di un insegnante dotto e paziente. (Nella stessa borgata andrà ad abitare con la sua famiglia Domenico Savio, dal novembre 1843 al settembre del 1853, nella casa Viale, e ora Pianta, poco distante dalla Cappella).
La borgata di Morialdo, formata da piccole frazioni e da cascine sparse tra le verdi colline, comprendeva anche i casolari dei Becchi che confinavano con Capriglio. Il cappellano era Don Calosso, che aveva rivolto a Giovanni l'invito di andarlo a trovare. Il ragazzo aderì e percorrendo due chilometri di strada, giunse di buon mattino a Morialdo. Quel giorno, una nuova speranza si accese nel suo cuore: finalmente avrebbe potuto studiare sul serio e sotto la guida di un insegnante dotto e paziente. (Nella stessa borgata andrà ad abitare con la sua famiglia Domenico Savio, dal novembre 1843 al settembre del 1853, nella casa Viale, e ora Pianta, poco distante dalla Cappella). -
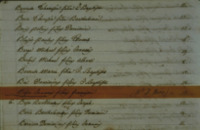 A quei tempi nei paesi di campagna l'amministrazione della Cresima non avveniva tutti gli anni. Nell'archivio della chiesa parrocchiale di Buttigliera d'Asti, si conserva l'elenco dei 72 cresimati del 1833, tra cui figura il nome di Giovanni Bosco (cf MB 1,277). Padrino per tutti il sindaco Giuseppe Marzano, e madrina Melina Giuseppina, contessa di Capriglio.
A quei tempi nei paesi di campagna l'amministrazione della Cresima non avveniva tutti gli anni. Nell'archivio della chiesa parrocchiale di Buttigliera d'Asti, si conserva l'elenco dei 72 cresimati del 1833, tra cui figura il nome di Giovanni Bosco (cf MB 1,277). Padrino per tutti il sindaco Giuseppe Marzano, e madrina Melina Giuseppina, contessa di Capriglio. -
 Le prediche a Buttigliera si tenevano in questa chiesa, dedicata a san Biagio. Costruita e ampliata a più riprese, venne coronata con l'erezione di un artistico campanile, che a ragione è considerato come uno dei più belli del Piemonte. Eretto nel 1789, domina sulle campagne circostanti, e per la sua altezza costituisce l'ornamento più nobile del paese. In questa chiesa Giovanni Bosco ricevette la Cresima il 4 agosto 1833 all'età di 18 anni, dalle mani di mons. Gianotti, vescovo di Sassari.
Le prediche a Buttigliera si tenevano in questa chiesa, dedicata a san Biagio. Costruita e ampliata a più riprese, venne coronata con l'erezione di un artistico campanile, che a ragione è considerato come uno dei più belli del Piemonte. Eretto nel 1789, domina sulle campagne circostanti, e per la sua altezza costituisce l'ornamento più nobile del paese. In questa chiesa Giovanni Bosco ricevette la Cresima il 4 agosto 1833 all'età di 18 anni, dalle mani di mons. Gianotti, vescovo di Sassari. -
 Lo storico incontro con Don Calosso, che segnò la sua vita di contadino che aspirava al sacerdozio, avvenne proprio lungo questa discesa, che da Buttigliera solca i vigneti e i prati.
Lo storico incontro con Don Calosso, che segnò la sua vita di contadino che aspirava al sacerdozio, avvenne proprio lungo questa discesa, che da Buttigliera solca i vigneti e i prati. -
 A 4 chilometri dai Becchi esiste un importante centro agricolo: Buttigliera d'Asti. Giovanni vi andava con la famiglia per le fiere e i mercati. Ma questo paese è legato alla nostra storia per un avvenimento particolare: il Giubileo, indetto da Pio VIII nel 1829. A Buttigliera si tennero predicazioni straordinarie che videro Giovanni assiduo ascoltatore. Aveva allora quattordici anni. Una di quelle sere, tra il 5 e il 7 novembre, sulla via del ritorno, egli si incontrò con Don Giuseppe Calosso, cappellano di Morialdo. Il sacerdote, colpito dalla vivacità del ragazzo, l'invitò a ripetergli il sunto della predica udita. L'esatta ripetizione fece strabiliare il cappellano: dopo altre domande, invitò Giovanni a casa sua (cf MB 1,178).
A 4 chilometri dai Becchi esiste un importante centro agricolo: Buttigliera d'Asti. Giovanni vi andava con la famiglia per le fiere e i mercati. Ma questo paese è legato alla nostra storia per un avvenimento particolare: il Giubileo, indetto da Pio VIII nel 1829. A Buttigliera si tennero predicazioni straordinarie che videro Giovanni assiduo ascoltatore. Aveva allora quattordici anni. Una di quelle sere, tra il 5 e il 7 novembre, sulla via del ritorno, egli si incontrò con Don Giuseppe Calosso, cappellano di Morialdo. Il sacerdote, colpito dalla vivacità del ragazzo, l'invitò a ripetergli il sunto della predica udita. L'esatta ripetizione fece strabiliare il cappellano: dopo altre domande, invitò Giovanni a casa sua (cf MB 1,178). -
 Così, reduce dalla cascina Moglia, Giovanni rivide la borgata dei Becchi dopo un'assenza di circa due anni. Ma ben presto vennero le delusioni: non si riusciva a trovargli né una scuola né un maestro. Dovette allora riprendere a fare il contadino, aspettando tempi migliori (et MB 1,208-210).
Così, reduce dalla cascina Moglia, Giovanni rivide la borgata dei Becchi dopo un'assenza di circa due anni. Ma ben presto vennero le delusioni: non si riusciva a trovargli né una scuola né un maestro. Dovette allora riprendere a fare il contadino, aspettando tempi migliori (et MB 1,208-210). -
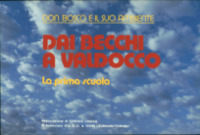 Dai Becchi a Valdocco La prima scuola
Dai Becchi a Valdocco La prima scuola -
 Un giorno di fine autunno 1829, lo zio materno Michele, passato di là a trovare il nipote e saputo che persisteva vivo in lui il desiderio di continuare gli studi, volle che tornasse a casa: avrebbe provveduto lui a farlo studiare. I Moglia soffrirono molto per la sua partenza (cf MB 1, 205s), ma Giovanni, acceso di nuova speranza, diede l'addio a quei luoghi a lui cari. Più tardi definirà il periodo passato alla cascina Moglia tra i più belli della sua giovinezza.
Un giorno di fine autunno 1829, lo zio materno Michele, passato di là a trovare il nipote e saputo che persisteva vivo in lui il desiderio di continuare gli studi, volle che tornasse a casa: avrebbe provveduto lui a farlo studiare. I Moglia soffrirono molto per la sua partenza (cf MB 1, 205s), ma Giovanni, acceso di nuova speranza, diede l'addio a quei luoghi a lui cari. Più tardi definirà il periodo passato alla cascina Moglia tra i più belli della sua giovinezza. -
 Sul muro della casa è stata murata una lapide ricordo e il busto del Santo. Uno dei discendenti dei Moglia per parte materna, Carlo Casalegno, attuale proprietario della cascina, li volle mettere il 22 ottobre 1969 in segno di perenne gratitudine per i tanti benefici ricevuti da Don Bosco. Una lapide e un carro di fieno: ricordano le due forze su cui si formò la vita del futuro apostolo della gioventù: il lavoro e la preghiera. Sono gli stessi elementi che daranno in seguito forza ed efficacia della sua opera educativa. Giovanni si avviava a concludere il suo secondo anno di permanenza alla cascina Moglia. Ma quella vita non gli offriva nessuna prospettiva di realizzare il suo ideale di diventare sacerdote.
Sul muro della casa è stata murata una lapide ricordo e il busto del Santo. Uno dei discendenti dei Moglia per parte materna, Carlo Casalegno, attuale proprietario della cascina, li volle mettere il 22 ottobre 1969 in segno di perenne gratitudine per i tanti benefici ricevuti da Don Bosco. Una lapide e un carro di fieno: ricordano le due forze su cui si formò la vita del futuro apostolo della gioventù: il lavoro e la preghiera. Sono gli stessi elementi che daranno in seguito forza ed efficacia della sua opera educativa. Giovanni si avviava a concludere il suo secondo anno di permanenza alla cascina Moglia. Ma quella vita non gli offriva nessuna prospettiva di realizzare il suo ideale di diventare sacerdote. -
 Il fienile che vediamo in alto ricorda l'episodio dell'Angelus. In una giornata estiva, Giuseppe Moglia se ne tornava a casa dai campi sul mezzogiorno, con la zappa in spalla, tutto sudato. In lontananza una campana invitava alla recita dell'Angelus. Alzando lo sguardo vide Giovanni che, rientrato poco prima, in ginocchio recitava la preghiera. Guarda là — esclamò ridendo —; noi padroni ci logoriamo la vita a lavorare e lui se ne sta tranquillo a pregare!. Giovanni, terminata la preghiera, rispettosamente rispose: Voi sapete che io non mi sono mai risparmiato sul lavoro; è vero però che io ho guadagnato più a pregare che voi a lavorare (ci MB 1, 197).
Il fienile che vediamo in alto ricorda l'episodio dell'Angelus. In una giornata estiva, Giuseppe Moglia se ne tornava a casa dai campi sul mezzogiorno, con la zappa in spalla, tutto sudato. In lontananza una campana invitava alla recita dell'Angelus. Alzando lo sguardo vide Giovanni che, rientrato poco prima, in ginocchio recitava la preghiera. Guarda là — esclamò ridendo —; noi padroni ci logoriamo la vita a lavorare e lui se ne sta tranquillo a pregare!. Giovanni, terminata la preghiera, rispettosamente rispose: Voi sapete che io non mi sono mai risparmiato sul lavoro; è vero però che io ho guadagnato più a pregare che voi a lavorare (ci MB 1, 197). -
 Il parroco, il teologo Cottino, che conobbe fin dai primi giorni Giovanni, notò in lui una devozione sincera, conobbe il buono spirito che lo animava, e lo appoggiò. Con il suo aiuto Giovanni ottenne la sala della scuola comunale a sua disposizione. Nei giorni festivi i giovani del paese si fermavano a fare solennemente la Via Crucis, e poi nella sala incominciavano i trattenimenti con la lettura di un libro di devozione, e ascoltavano i racconti di Giovanni. Egli poi li divertiva con i giochi e con la sua allegra inventiva. Era un primo inizio di oratorio festivo.
Il parroco, il teologo Cottino, che conobbe fin dai primi giorni Giovanni, notò in lui una devozione sincera, conobbe il buono spirito che lo animava, e lo appoggiò. Con il suo aiuto Giovanni ottenne la sala della scuola comunale a sua disposizione. Nei giorni festivi i giovani del paese si fermavano a fare solennemente la Via Crucis, e poi nella sala incominciavano i trattenimenti con la lettura di un libro di devozione, e ascoltavano i racconti di Giovanni. Egli poi li divertiva con i giochi e con la sua allegra inventiva. Era un primo inizio di oratorio festivo. -
 Nei giorni di festa il lavoro dei campi si fermava. Ma Giovanni non conosceva riposo. La domenica mattina, prestissimo, prese ad andare a Moncucco per confessarsi, ascoltare la Messa e fare la Comunione. Ben presto, avuta l'approvazione del parroco Don Cottino, organizzò come un piccolo oratorio, radunando i giovani per buona parte della giornata, intrattenendoli con la sua inventiva e serenità e guidandoli nella preghiera. Rientrava in cascina alla sera, cantando felice, pur nella sua stanchezza (cf MB 1, 195; 202).
Nei giorni di festa il lavoro dei campi si fermava. Ma Giovanni non conosceva riposo. La domenica mattina, prestissimo, prese ad andare a Moncucco per confessarsi, ascoltare la Messa e fare la Comunione. Ben presto, avuta l'approvazione del parroco Don Cottino, organizzò come un piccolo oratorio, radunando i giovani per buona parte della giornata, intrattenendoli con la sua inventiva e serenità e guidandoli nella preghiera. Rientrava in cascina alla sera, cantando felice, pur nella sua stanchezza (cf MB 1, 195; 202). -
 A circa un'ora di cammino dalla cascina Moglia, attraverso sentieri in mezzo alle colline, si raggiungeva il paese di Moncucco. Là dovevano recarsi gli abitanti della borgata per la Messa domenicale. Ma questo non poteva bastare a Giovannino, sempre assetato di Dio.
A circa un'ora di cammino dalla cascina Moglia, attraverso sentieri in mezzo alle colline, si raggiungeva il paese di Moncucco. Là dovevano recarsi gli abitanti della borgata per la Messa domenicale. Ma questo non poteva bastare a Giovannino, sempre assetato di Dio. -
 Questa vecchietta che rimesta la polenta nel paiolo e la scodella sulla tavola, simboleggiano l'accoglienza affettuosa che Giovanni trovò nella cascina Moglia. Fin dall'inizio fu considerato uno della famiglia. Egli fece di tutto per ricambiare la stima di cui lo circondavano, né mai si tirò indietro di fronte ad un servizio, per quanto umile e faticoso. Si può dire che fu sempre il beniamino della signora Dorotea, che gli insegnò a recitar bene le litanie della Madonna e lo incaricò di guidare le preghiere della famiglia (cf MB 1,195).
Questa vecchietta che rimesta la polenta nel paiolo e la scodella sulla tavola, simboleggiano l'accoglienza affettuosa che Giovanni trovò nella cascina Moglia. Fin dall'inizio fu considerato uno della famiglia. Egli fece di tutto per ricambiare la stima di cui lo circondavano, né mai si tirò indietro di fronte ad un servizio, per quanto umile e faticoso. Si può dire che fu sempre il beniamino della signora Dorotea, che gli insegnò a recitar bene le litanie della Madonna e lo incaricò di guidare le preghiere della famiglia (cf MB 1,195). -
 Ecco la cantina seminterrata della cascina dove Giovanni prestava la sua collaborazione alla pigiatura dell'uva, alla spulatura del vino e alla pulizia delle botti. Questo lavoro gravoso era affidato sovente ai ragazzi più snelli e agili nel calarsi nelle capaci botti per togliere i graspi, pulirle dalle vinacce, e per riporre il mosto conservato fino a fermentazione avvenuta.
Ecco la cantina seminterrata della cascina dove Giovanni prestava la sua collaborazione alla pigiatura dell'uva, alla spulatura del vino e alla pulizia delle botti. Questo lavoro gravoso era affidato sovente ai ragazzi più snelli e agili nel calarsi nelle capaci botti per togliere i graspi, pulirle dalle vinacce, e per riporre il mosto conservato fino a fermentazione avvenuta. -
 Grappoli abbondanti, succosi e freschi!... Così dovevano essere quelli prodotti dai filari piantati da Giovanni nelle proprietà dei Moglia. Le sue parole profetiche (ricordate al MB 1,35), furono accolte con un sorriso incredulo, ma più tardi i padroni ne testimoniarono l'avveramento con fierezza e gratitudine (cf MB 1, 206).
Grappoli abbondanti, succosi e freschi!... Così dovevano essere quelli prodotti dai filari piantati da Giovanni nelle proprietà dei Moglia. Le sue parole profetiche (ricordate al MB 1,35), furono accolte con un sorriso incredulo, ma più tardi i padroni ne testimoniarono l'avveramento con fierezza e gratitudine (cf MB 1, 206). -
 I vigneti, insieme alla stalla, erano la migliore risorsa della cascina. Perciò la sollecita cura delle viti costituiva la parte preponderante del lavoro. Bisognava potare, zappare, concimare, irrorare e dare lo zolfo e il verderame. E finalmente, dopo tanti mesi di fatiche, la vendemmia, sempre sperando che non venisse la grandine a distruggerla.
I vigneti, insieme alla stalla, erano la migliore risorsa della cascina. Perciò la sollecita cura delle viti costituiva la parte preponderante del lavoro. Bisognava potare, zappare, concimare, irrorare e dare lo zolfo e il verderame. E finalmente, dopo tanti mesi di fatiche, la vendemmia, sempre sperando che non venisse la grandine a distruggerla. -
 Quando la calura era grande, Giovanni cercava riparo all'ombra di questo gelso. Qui sorvegliava e trastullava il piccolo Giorgio di 3 anni, figlio del padrone. Nei momenti liberi poi soleva radunare presso quest'albero i suoi amici giovani e meno giovani per intrattenerli con giochi vari, racconti edificanti ed esibizioni acrobatiche (cf MB 1, 200). D'inverno il luogo di riunione era il capace fienile che egli sceglieva per non disturbare o essere disturbato (cf MB 1, 199).
Quando la calura era grande, Giovanni cercava riparo all'ombra di questo gelso. Qui sorvegliava e trastullava il piccolo Giorgio di 3 anni, figlio del padrone. Nei momenti liberi poi soleva radunare presso quest'albero i suoi amici giovani e meno giovani per intrattenerli con giochi vari, racconti edificanti ed esibizioni acrobatiche (cf MB 1, 200). D'inverno il luogo di riunione era il capace fienile che egli sceglieva per non disturbare o essere disturbato (cf MB 1, 199). -
 Tra le varie incombenze di Giovanni c'era anche quella di condurre i buoi che tiravano l'aratro. Questa inquadratura agreste ci richiama alla mente le tante volte che egli svolse la stessa occupazione. Ma il lavoro non lo distoglieva mai completamente dagli studi. Egli, infatti, teneva sempre un libro a portata di mano, e quando poteva vi dava una sbirciatina (cf MB 1, 200).
Tra le varie incombenze di Giovanni c'era anche quella di condurre i buoi che tiravano l'aratro. Questa inquadratura agreste ci richiama alla mente le tante volte che egli svolse la stessa occupazione. Ma il lavoro non lo distoglieva mai completamente dagli studi. Egli, infatti, teneva sempre un libro a portata di mano, e quando poteva vi dava una sbirciatina (cf MB 1, 200). -
 Ma il lavoro che richiedeva maggior fatica era la mietitura del frumento e dei cereali sotto il cocente sole estivo. Con la schiena curva, la falce in mano e il corpo bagnato di sudore, i contadini falciavano il grano a grosse manciate e lo componevano in fasci, detti covoni. I violenti acquazzoni e ancor più le grandinate erano i pericoli peggiori di questa stagione. La violenza delle intemperie, infatti, rischiava di vanificare il lavoro di un intero anno rovinando, interamente o in parte, il raccolto, con conseguenti, terribili carestie, ricordate più volte negli annali dell'agricoltura astigiana, ma anche nelle Memorie Biografiche di Don Bosco.
Ma il lavoro che richiedeva maggior fatica era la mietitura del frumento e dei cereali sotto il cocente sole estivo. Con la schiena curva, la falce in mano e il corpo bagnato di sudore, i contadini falciavano il grano a grosse manciate e lo componevano in fasci, detti covoni. I violenti acquazzoni e ancor più le grandinate erano i pericoli peggiori di questa stagione. La violenza delle intemperie, infatti, rischiava di vanificare il lavoro di un intero anno rovinando, interamente o in parte, il raccolto, con conseguenti, terribili carestie, ricordate più volte negli annali dell'agricoltura astigiana, ma anche nelle Memorie Biografiche di Don Bosco. -
 Infine si caricava col tridente il fieno sul carro agricolo, trainato da una coppia di mucche o di buoi. Il raccolto veniva così portato sull'aia di casa, sistemato nel fienile e conservato come foraggio invernale per le bestie. A volte temporali improvvisi facevano accelerare i lavori. Allora il ritmo diventava frenetico: era una lotta contro il tempo per evitare che il fieno si inzuppasse d'acqua.
Infine si caricava col tridente il fieno sul carro agricolo, trainato da una coppia di mucche o di buoi. Il raccolto veniva così portato sull'aia di casa, sistemato nel fienile e conservato come foraggio invernale per le bestie. A volte temporali improvvisi facevano accelerare i lavori. Allora il ritmo diventava frenetico: era una lotta contro il tempo per evitare che il fieno si inzuppasse d'acqua. -
 A maggio, poi, veniva la falciatura del fieno nei prati: un lavoro duro e faticoso riservato agli uomini più robusti, ma al quale tutti collaboravano per spandere, voltare e rastrellare il fieno. A quei tempi era molto sentito lo spirito di solidarietà e di collaborazione: i contadini dei vari poderi si aiutavano volentieri gli uni gli altri a falciare, raccogliere e sistemare il fieno in cascina.
A maggio, poi, veniva la falciatura del fieno nei prati: un lavoro duro e faticoso riservato agli uomini più robusti, ma al quale tutti collaboravano per spandere, voltare e rastrellare il fieno. A quei tempi era molto sentito lo spirito di solidarietà e di collaborazione: i contadini dei vari poderi si aiutavano volentieri gli uni gli altri a falciare, raccogliere e sistemare il fieno in cascina. -
 La primavera segnava l'inizio dei lavori pesanti. In questa stagione infatti si iniziava a fare lo scasso e a piantare le viti, a vangare, a potare, a legare i tralci ai pali e a zappare. Giovanni Moglia aveva condotto il giovane Bosco una mattina a piantare quattro nuovi filari di viti. Ad un dato momento il ragazzo, stanco, disse che non ne poteva più dal mal di schiena e alle ginocchia, dovendo lavorare tutto curvo. Esortato a riprendere il lavoro, ad un tratto disse: Queste viti che io sto legando, faranno l'uva più bella, daranno il miglior vino e in maggiore quantità, e dureranno più delle altre (MB 1, 206).
La primavera segnava l'inizio dei lavori pesanti. In questa stagione infatti si iniziava a fare lo scasso e a piantare le viti, a vangare, a potare, a legare i tralci ai pali e a zappare. Giovanni Moglia aveva condotto il giovane Bosco una mattina a piantare quattro nuovi filari di viti. Ad un dato momento il ragazzo, stanco, disse che non ne poteva più dal mal di schiena e alle ginocchia, dovendo lavorare tutto curvo. Esortato a riprendere il lavoro, ad un tratto disse: Queste viti che io sto legando, faranno l'uva più bella, daranno il miglior vino e in maggiore quantità, e dureranno più delle altre (MB 1, 206). -
 In primo piano il carro agricolo a cui si aggiogavano le mucche, per i vari trasporti nella cascina. In secondo piano, addossato alla facciata, il pozzo dal quale Giovanni attingeva l'acqua per gli usi domestici e per il bestiame; un lavoro abbastanza faticoso. Il pozzo esiste tutt'ora.
In primo piano il carro agricolo a cui si aggiogavano le mucche, per i vari trasporti nella cascina. In secondo piano, addossato alla facciata, il pozzo dal quale Giovanni attingeva l'acqua per gli usi domestici e per il bestiame; un lavoro abbastanza faticoso. Il pozzo esiste tutt'ora. -
 Altro lavoro gravoso per Giovanni era attingere con un secchio di legno (siun) l'acqua necessaria per abbeverare il bestiame, tre volte al giorno. Una corda, che scorreva nella scanalatura di una ruota di ghisa o di legno, e alla quale era agganciato il secchio al cainas, veniva fatta scendere e salire a braccia, e l'acqua veniva versata in una tinozza di legno.
Altro lavoro gravoso per Giovanni era attingere con un secchio di legno (siun) l'acqua necessaria per abbeverare il bestiame, tre volte al giorno. Una corda, che scorreva nella scanalatura di una ruota di ghisa o di legno, e alla quale era agganciato il secchio al cainas, veniva fatta scendere e salire a braccia, e l'acqua veniva versata in una tinozza di legno. -
 Giovannino, come garzone, fece tutti i lavori che comportava la manutenzione di una stalla: foraggiava le bestie, le abbeverava, le mungeva, ne preparava il letto con paglia o foglie di granturco... Col bel tempo le conduceva al pascolo nei prati circostanti, dove alternava la cura degli animali con la lettura del catechismo e con la preghiera (cf MB 1,196; 198). Il padrone Moglia, apprezzando il servizio di Giovanni e vedendolo tanto desideroso di studiare, un giorno gli disse: Resta inteso che, terminati i tuoi lavori, puoi ritirarti e studiare quanto vuoi.
Giovannino, come garzone, fece tutti i lavori che comportava la manutenzione di una stalla: foraggiava le bestie, le abbeverava, le mungeva, ne preparava il letto con paglia o foglie di granturco... Col bel tempo le conduceva al pascolo nei prati circostanti, dove alternava la cura degli animali con la lettura del catechismo e con la preghiera (cf MB 1,196; 198). Il padrone Moglia, apprezzando il servizio di Giovanni e vedendolo tanto desideroso di studiare, un giorno gli disse: Resta inteso che, terminati i tuoi lavori, puoi ritirarti e studiare quanto vuoi. -
 Ben presto la sua bontà e continua disponibilità gli guadagnarono l'affetto dell'intera famiglia Moglia (cf MB 1,198; 206). Fu trattato come un figlio. In questa nitida e spaziosa cameretta egli riposava dopo le faticose giornate e poteva ritirarsi a studiare e pregare. L'ideale di diventare sacerdote non lo abbandonava mai, né aveva vergogna a palesarlo (cf MB 1, 200; 207). Una volta realizzato il suo sogno, accoglierà sempre i suoi antichi padroni come ospiti graditi (cf MB 1, 206-208).
Ben presto la sua bontà e continua disponibilità gli guadagnarono l'affetto dell'intera famiglia Moglia (cf MB 1,198; 206). Fu trattato come un figlio. In questa nitida e spaziosa cameretta egli riposava dopo le faticose giornate e poteva ritirarsi a studiare e pregare. L'ideale di diventare sacerdote non lo abbandonava mai, né aveva vergogna a palesarlo (cf MB 1, 200; 207). Una volta realizzato il suo sogno, accoglierà sempre i suoi antichi padroni come ospiti graditi (cf MB 1, 206-208).